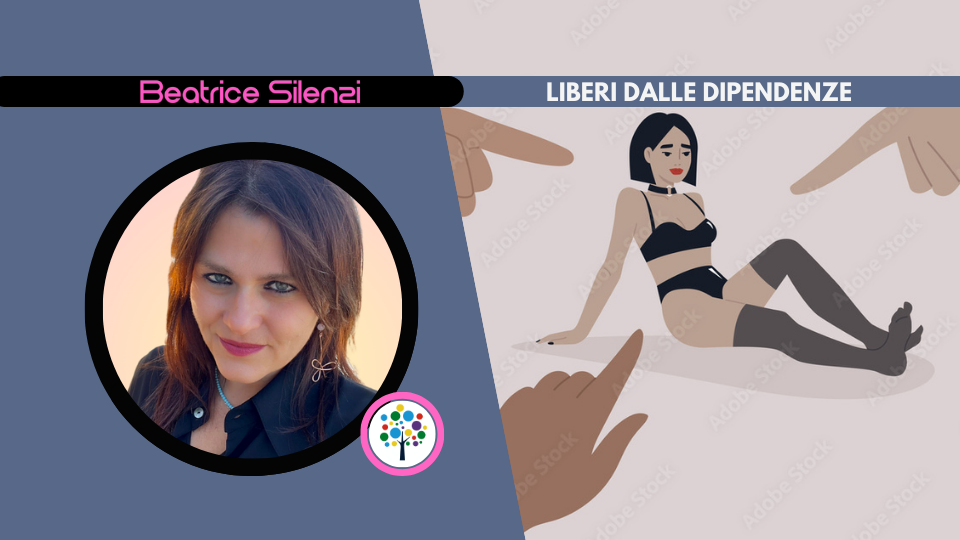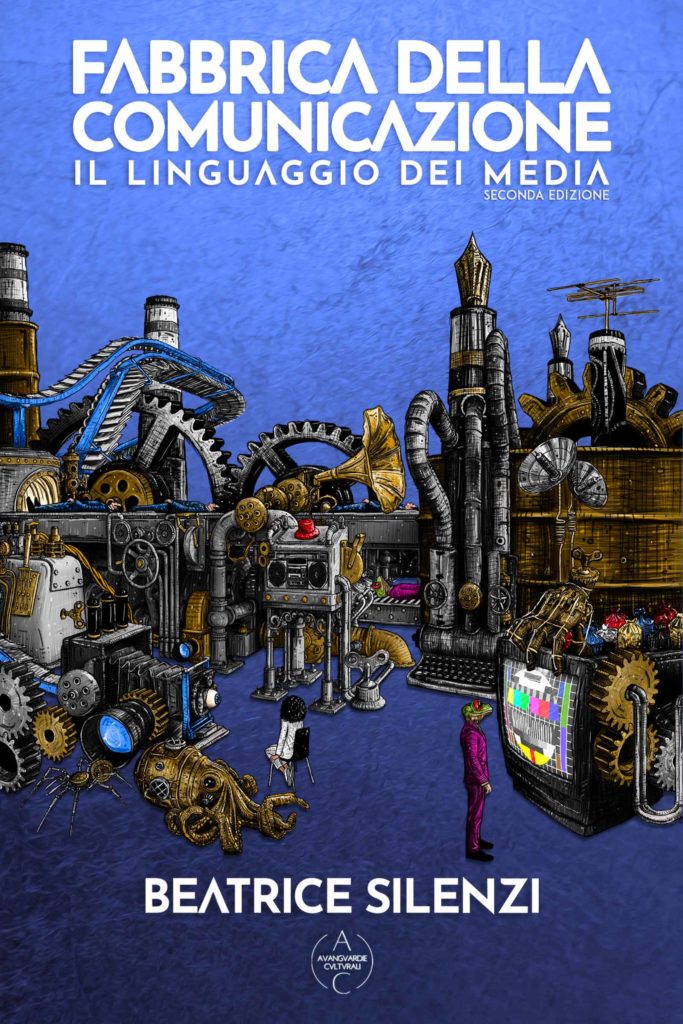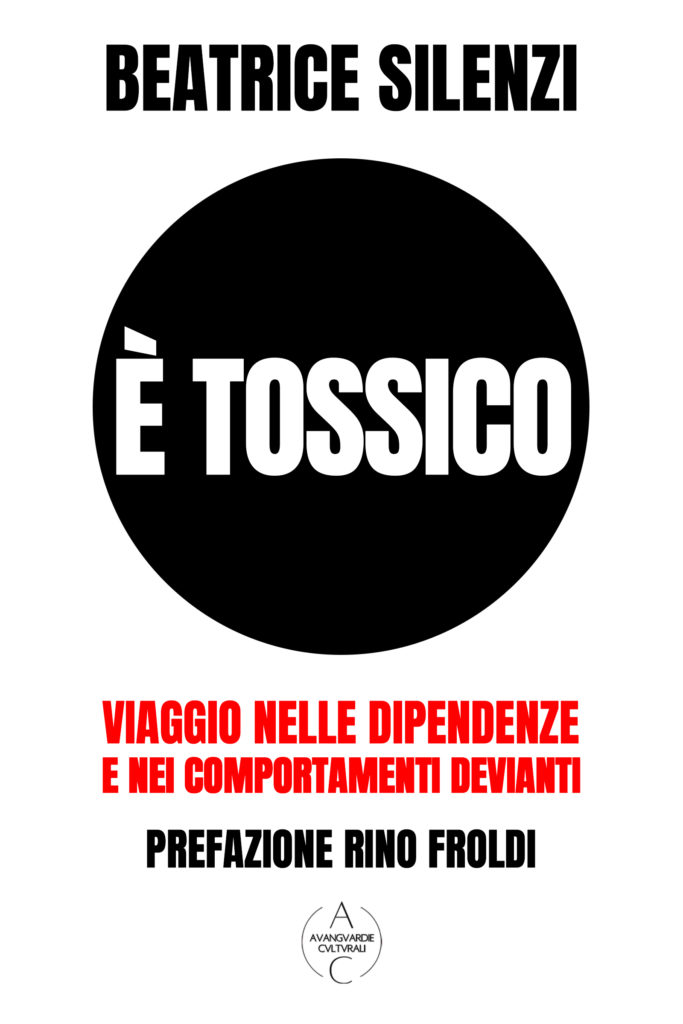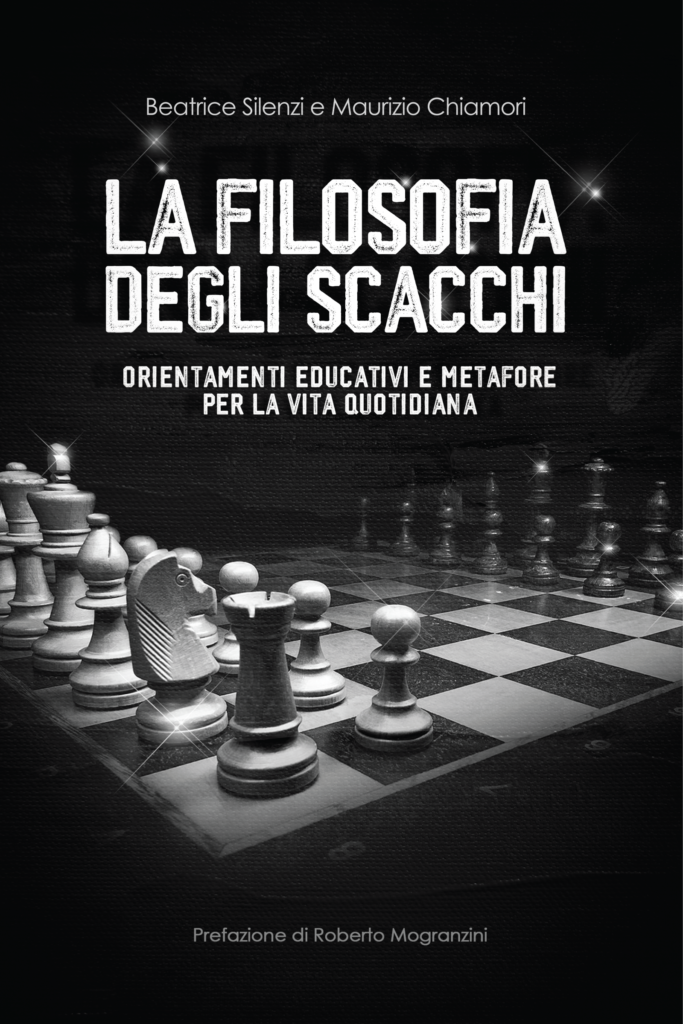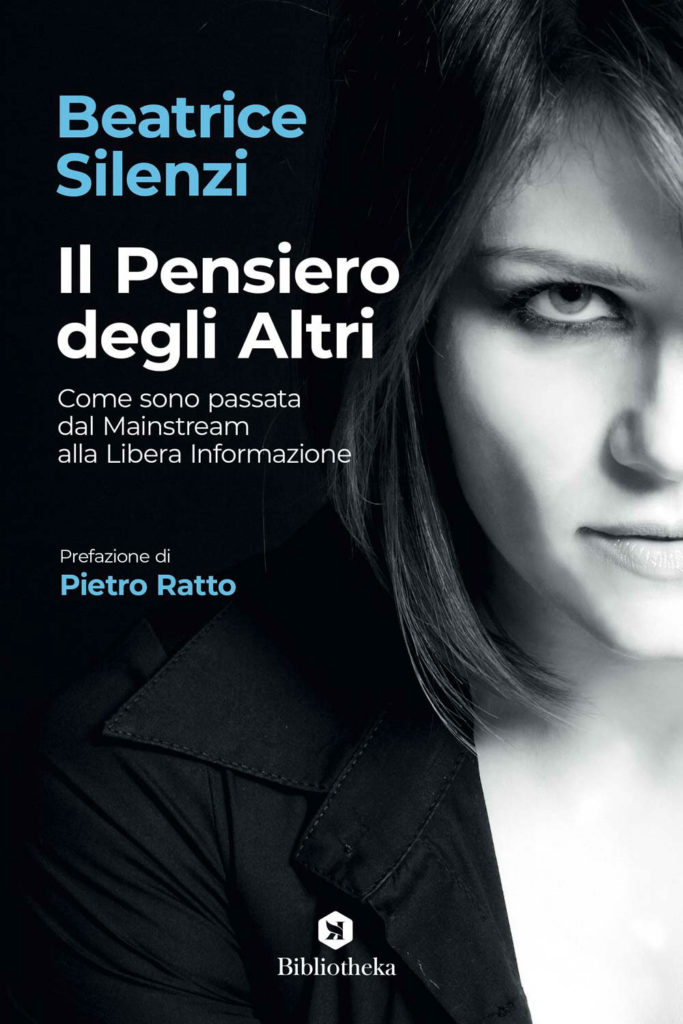L’arma invisibile del controllo sul corpo delle donne è lo Slut-Shaming e, nel dibattito pubblico contemporaneo, è un termine che è emerso con forza, in questi ultimi mesi.
Chi non ricorda la vicenda occorsa l’estate scorsa all’attrice Nicoletta Romanoff, giudicata dal medico che la stava assistendo durante il parto – come lei stessa riferiva – “perché ho avuto quattro figli da tre uomini diversi e non me lo aspettavo. Ma è un giudizio al quale sono purtroppo abituata”.
Il racconto, tratto dal suo libro, come pure altri casi in cui le donne frequentemente si trovano, ha riportato alla luce un episodio che va oltre il semplice aneddoto, ma semmai rappresenta un segno tangibile di quanto il pregiudizio e il moralismo sulle scelte affettive e familiari delle donne siano ancora profondamente radicati.
Passando dai circoli accademici femministi al linguaggio comune Slut-Shaming è un fenomeno radicato, pericoloso e subdolo.
Traducibile come “stigma della puttana” o “umiliazione da sgualdrina”, è più di un insulto: è un sofisticato meccanismo di controllo sociale che mira a sanzionare e regolare la sessualità femminile.
Nato in ambito filosofico femminista, il termine descrive l’atto di far sentire una donna colpevole, inferiore o “sbagliata” per i suoi comportamenti, desideri o anche solo per il suo aspetto, qualora questi si discostino dalle aspettative di genere tradizionali.
Si tratta di una gogna sociale che colpisce le donne per aver trasgredito codici di condotta non scritti, ma profondamente interiorizzati dalla società.
Come sottolinea, tra gli altri, la studiosa Emily Bazelon, lo slut-shaming traccia una linea netta e arbitraria: “una ragazza può essere sessuale, ma non troppo sessuale”. Una “linea” che definisce il perimetro di una femminilità accettabile, punendo chiunque osi attraversarla.
Come si esplica?
▪️ Abbigliamento. Una donna che indossa abiti considerati “provocanti” viene immediatamente etichettata e giudicata, come se la sua scelta estetica fosse un invito o una dichiarazione morale.
▪️ Comportamento sessuale. L’avere più partner, l’essere sessualmente proattive o semplicemente il parlare apertamente di sesso può scatenare un’ondata di giudizi.
▪️ Autodeterminazione. Anche la semplice richiesta di accesso a metodi contraccettivi o informazioni sulla salute sessuale può essere vista come prova di una condotta “promiscua”.
Dallo stigma alla colpevolizzazione della vittima è la deriva più pericolosa
La funzione più nefasta del fenomeno si manifesta nel suo legame indissolubile con la colpevolizzazione della vittima (victim-blaming). In casi di molestie, aggressioni sessuali o stupri, questo meccanismo perverso sposta il focus e la responsabilità dall’aggressore alla vittima.
Frasi come “se l’è cercata”, “guarda com’era vestita” o “con quel comportamento cosa si aspettava?” sono la diretta conseguenza di una cultura che ha preventivamente giudicato quella donna sulla base del suo presunto comportamento sessuale.
In questo modo, lo slut-shaming non solo umilia, ma fornisce anche una giustificazione pseudo-logica per la violenza, assolvendo di fatto il carnefice e infliggendo alla vittima un doppio trauma: quello dell’aggressione e quello della colpa.
Quando sono le donne a colpire le donne?
Un aspetto cruciale, e spesso sottovalutato, è che lo slut-shaming è una dinamica profondamente radicata anche nelle interazioni femminili. La ricercatrice Jessica Ringrose ha evidenziato come, tra donne, possa funzionare come un modo per “sublimare la gelosia sessuale in una forma socialmente accettabile di critica sociale”.
In un sistema in cui le donne sono spesso in competizione tra loro, giudicare il comportamento sessuale di un’altra donna diventa un modo per riaffermare la propria “rispettabilità” e aderenza alle norme, guadagnando così una posizione di presunta superiorità morale.
È un meccanismo che indebolisce la solidarietà femminile e perpetua gli stessi standard oppressivi che colpiscono tutte.
È un sintomo di una cultura ancora intrisa di doppi standard, dove la sessualità maschile è incoraggiata come segno di virilità, mentre quella femminile è tollerata solo entro confini strettissimi.
Combatterlo significa innanzitutto riconoscerlo, nominarlo e smascherarne le logiche. Richiede un profondo lavoro educativo che promuova il rispetto per l’autodeterminazione e la libertà individuale, slegando il valore di una persona dalle sue scelte sessuali o dal suo modo di vestire.
Superare lo stigma è un passo fondamentale non solo per la sicurezza delle donne, ma per la costruzione di una società in cui la parità sia una realtà vissuta e non solo un ideale dichiarato e di rapporti disfunzionali parlo diffusamente nel libro “È Tossico: Viaggio nelle Dipendenze e nei Comportamenti Devianti”